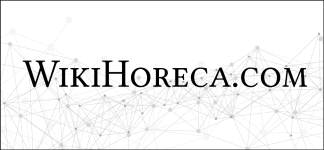L’azienda vitivinicola Cieck celebra le sue prime 40 vendemmie. Fondata nel 1985 ad Aglié, vicino a San Giorgio, l’impresa è nata come un piccolo progetto di spumantistica. Remo, nato nel 1933, figlio di contadini e progettista di macchine da scrivere all’Olivetti, intraprende un viaggio in Francia per apprendere l’arte della produzione di spumante. Nel 1985, con pochi ettari di vigneto, avvia la vinificazione del suo primo Erbaluce Metodo Classico, producendo circa 2500 bottiglie. Questo vino debutta sul mercato nel 1987, segnando l’inizio dell’attività dell’azienda, che prende il nome dalla vecchia cascina di Aglié dove è cominciata. Ora la cantina si è trasferita in località Castagnola a San Giorgio Canavese, tra Torino e Ivrea. Coltiva 15 ettari di vigneti. È quasi tutto Erbaluce, vitigno bianco antico e autoctono del Canavese. Il resto sono sempre vitigni autoctoni: Nebbiolo, Barbera, Neretto, Freisa. La particolarità di questa zona sono i vigneti a pergola, ovvero un sistema di allevamento che crea appunto degli ampi pergolati in vigna. L’uva si vendemmia raccogliendo i grappoli in alto.
Chi è Cieck
Cieck sono in tre: Domenico Caretto è l’agronomo e si occupa dei vigneti e della cantina; Lia Falconieri si occupa dell’amministrazione, della parte commerciale e della comunicazione; Remo Falconieri, il fondatore, «l’Archimede delle bollicine» come lo battezzò Carlin Petrini, a 80 anni e più, ogni giorno alle 8 del mattino è il primo ad arrivare in cantina. La cantina si avvale della consulenza esterna dell’enologo Gianpiero Gerbi. Ora ha anche un giovane enologo interno Tommaso Scapino.
Vigneti con l’anima
Ogni vigneto ha un nome, un’anima, una storia. Il più antico è il Misobolo che oggi è il nome di un Erbaluce. Qui c’è ancora una vite a piede franco che ha quasi un secolo di vita. Fu impiantata prima dell’attacco di filossera di inizio 900. La custodiscono con cura. Misobolo è un nome catastale storico del paese: vi si trova un santuario dove è seppellita Teresa Belloch, cantante lirica, musa di Giocchino Rossini. Qui produceva l’uva a fine 800 Pietro Falconieri, trisavolo di Lia. Affascinato dal metodo Martinotti, appena nato, provò a farlo anche lui con una botte molto robusta. Era il «vin sfursà» che si teneva a fermentare spontaneamente nella botticella fino alla settimana di Pasqua quando era tempo di toglierlo dalla botte e berlo. Poi ci sono il vigneto Brajassa della Mariuccia, la zia di Domenico; il vigneto Castagnola; il vigneto Cascinetto; il vigneto Biaulej (delle Betulle). I vigneti di Freisa sono di Carlin, papà di Domenico. Continuano a coltivare per affetto anche due piccoli filari di pinot grigio di nonno Giacomo.
Vigneto Misobolo: sono i filari storici. Dal 1990 è il nome di un Erbaluce. Oggi viene rivendicata la menzione vigna. Circa 1,8 ettaro.
Vigneto Brajassa: era di proprietà della signora Mariuccia, la zia e madrina di Domenico. Più di un ettaro di Erbaluce.
Vigneto Castagnola: i filari che abbracciano la cantina nuova. Poco meno di un ettaro impiantato a Erbaluce.
Vigneto Cascinetto: è un piccolo vigneto piantato da Marilena e Remo, appena dopo le nozze nel 1968. Era tutta Erbaluce. Marilena ancora oggi beve solo vino bianco.
Vigneto Biaulej (delle Betulle): filari di nebbiolo, neretto e erbaluce

Cantina
La nuova cantina nasce nel 2013 nel cuore dei filari di Erbaluce, in un vigneto già di proprietà dell’azienda a San Giorgio Canavese. Un progetto moderno, tecnologico e green insieme, per venire incontro alle nuove necessità dell’azienda e alle esigenze di risparmio energetico. Ci sono pannelli solari per la produzione di acqua calda, un impianto di fitodepurazione per il trattamento delle acque reflue in cantina, il riciclo dell’acqua piovana per il riutilizzo in cantina nella pulizia dei mezzi agricoli.
VASCHE: la zona di fermentazione è dotata di vasche in acciaio inox moderne termo-condizionate. Tutte le fermentazioni dei vini avvengono a temperatura controllata. La cella frigo serve per la conservazione delle uve in vendemmia in condizioni di caldo estremo. All’occorrenza può essere riscaldata per avviare la fermentazione malolattica nei vini rossi.
CANTINA DI AFFINAMENTO: qui avviene lo stoccaggio degli Spumanti Metodo Classico che riposano sui lieviti per molti mesi, e dei vini rossi che necessitano di affinamento. Vengono utilizzate barriques e tonneaux per l’affinamento dei vini bianchi, rossi e passiti. Le bottiglie di Metodo Classico vengono messe nelle pupitres dove si fa il remuage manuale ovvero la rotazione periodica delle bottiglie capovolte perché il sedimento si depositi sul tappo.
PASSITAIA: è la stanza dove avviene il processo di appassimento delle uve Erbaluce che diventeranno Alladium. L’appassimento è naturale, senza alcuna forzatura. Viene utilizzata ancora una tecnica tradizionale risalente all’800: i grappoli vengono selezionati e appesi a uno a uno su appositi telai. Questo permette una ventilazione dei grappoli maggiore e li preserva dallo sviluppo di muffe e batteri nocivi senza ostacolare l’azione della botritis, la muffa nobile, che caratterizza il passito. I grappoli restano lì per 4-5 mesi, da settembre a gennaio/febbraio. Poi gli acini vengono diraspati e pressati delicatamente. La prima fermentazione avviene in acciaio, poi il passito riposa per almeno 5 anni in piccole botti di rovere francese e di Slavonia. Le barrique permettono una buona ossigenazione, ma occorre ricolmare periodicamente perché il legno assorbe molto prodotto.
Il territorio
La terra del Canavese ha avuto origine dal Ghiacciaio Balteo che trascinò dalla Valle d’Aosta un terreno ricco di numerosi minerali. Ebbe così origine l’Anfiteatro Morenico di Ivrea, diviso a metà da un fiume: la Dora Baltea. Le varietà di minerali si ritrovano nel vino prodotto in queste terre ed è anche la peculiarità dei vini Cieck.
TERROIR: Le peculiarità dei vini Cieck sono collegate alle caratteristiche del clima e dei terreni dove sono impiantati i vigneti. La culla e la casa della denominazione Erbaluce di Caluso è rappresentata dall’Anfiteatro Morenico di Ivrea, nato dal ghiacciaio discendente dalla Valle d’Aosta durante il Pleistocene. I suoli si formarono dai detriti che furono trasportati e collocati dal ghiacciaio tra 900.000 e 19.000 anni fa, durante dieci periodi glaciali. Il suolo così formato è ricco di scheletro e costituito principalmente da sabbia, sassi e ciottoli. La valle della attuale Dora Baltea è l’unica a essere scavata attraverso tutte le grandi placche tettoniche delle Alpi. Per questa ragione l’Anfiteatro Morenico di Ivrea mostra una varietà di minerali più ampia rispetto a altri anfiteatri delle Alpi, con una ricca presenza di rocce metamorfiche sia silicatiche che carbonatiche. Questa particolare ricchezza di minerali conferisce ai vini una sapidità particolarmente ricca di sensazioni minerali.
L’ANFITEATRO MORENICO DI IVREA: Visto più in dettaglio, l’Anfiteatro Morenico di Ivrea è formato da rilievi bassi in forma di altopiano soprattutto sul versante meridionale: si coltiva Erbaluce tra 200 e fino a oltre i 500 metri sul livello del mare. Le zone vitate sorgono su terreni acidi e sciolti, di matrice molto recente e con buono scheletro, composti di sabbia, ciottoli e pietre e in minima parte di limo e argilla. Sono terreni poveri che stimolano poco la crescita della pianta. Tuttavia man mano che le radici delle viti si approfondiscono trovano negli strati inferiori terreno più ricco, in alcuni casi anche con discrete percentuali argillose.

I vitigni autoctoni
L’ERBALUCE: Le prime notizie del vitigno Erbaluce risalgono al 1606, menzionato da Giovan Battista Croce, gioielliere presso il duca Carlo Emanuele I, con il nome di «Elbalus». Riguardo alle sue origini, nel corso del tempo si sono formulate varie ipotesi: la prima è che discenda del Greco di Bianco e sia giunto in Canavese al seguito dell’esercito Romano dopo essere Partito dalla Tessaglia e transitato in Magna Grecia. La seconda è che la sua antenata sia una varietà di Clairette Blanche francese (diffusa in Cote du Rhone), e sia quindi imparentato con l’Airen spagnolo e il Rhoditis Greco, e sia poi giunto in Canavese nel periodo di Carlo Magno. L’ultima ipotesi, la più accreditata, è che si tratti di un vero vitigno autoctono canavesano, legato all’uva Rhaetica o Raetica, già citata all’epoca di Plinio il Vecchio (I sec. d.C.). Il bel nome antico del vitigno, Albalux, pare derivi dal colore che assumono gli acini in autunno: i riflessi rosati e caldi si fanno più intensi, ambrati, nelle parti esposte al sole. L’Erbaluce è uno dei vitigni più versatili: dà origine a tre tipologie distinte di vino nell’ambito di una stessa denominazione: vino bianco fermo, spumante metodo classico e passito. L’erbaluce ha la capacità di accumulare zuccheri fino a medie concentrazioni mantenendo un tenore acido notevole. L’elevata acidità naturale consente di ottenere un’ottima base spumante e dà ai vini la capacità di invecchiare. È inoltre ricco di estratto, ha potenziale alcolico medio basso, pochi aromi liberi, ma diversi precursori di aroma. L’erbaluce ha una buccia spessa, croccante, resistente. Lo spessore della buccia comporta una buona resistenza agli attacchi fungini e un ottimo sviluppo in un ambiente umido come quello del Canavese e consente ottimi risultati con la pressatura diretta, necessaria per realizzare un’ottima base spumante. Il grappolo inoltre si presenta mediamente spargolo, consentendo ottimi risultati con l’appassimento. Il riconoscimento della denominazione avvenne nel 1967: fu tra i primi vini italiani a essere tutelato. Il riconoscimento della Denominazione di origine controllata e garantita è avvenuto con Decreto dell’8 ottobre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 22.10.2010.
IL VIGNETO ERBALUCE: Il vigneto di Erbaluce è tradizionalmente un vigneto coltivato in forma di pergola. La pergola Canavesana o pergola di Caluso è a falda piatta di altezza compresa tra i 180 e i 200 cm. Il sesto di impianto medio è di 4 metri per 2 metri, che porta a una densità di impianto di 1300 piante per ettaro. La potatura tradizionale è detta «a tre punte» con tre capi a frutto con 10 gemme all’estremità. Vi è uno sperone, un capo a frutto, un capo a frutto di 2 anni e infine un terzo capo a frutto su un tralcio di tre anni. Questo sistema comporta che tutte le principali operazioni in vigneto, potatura, potatura verde e vendemmia debbano svolgersi a mano.
LA LEGGENDA DELLA NINFA ALBALUCE: Esiste anche una leggenda sull’origine dell’Erbaluce. Si narra che le colline moreniche formate dai ghiacciai fossero un tempo abitate da Ninfe. Un giorno la Ninfa Alba vide il Sole e s’innamorò. Un amore impossibile perché i due innamorati non potevano incontrarsi. Fu così che la Luna decise che, al sorgere del Sole, non avrebbe abbandonato la volta celeste, permettendo al Sole di raggiungere di nascosto la terra per incontrare la sua amata Ninfa Alba. Da quell’eclissi, nacque Albaluce, una meravigliosa creatura dalla pelle di rugiada, capelli lucenti e occhi azzurri. Così bella che divenne oggetto di venerazione finché le risorse del lago non bastarono più, e fu necessario ricavare nuova terra da coltivare. Si scavò un grande canale per far defluire le acque del lago ma le acque travolsero tutto, seminando morte. La ninfa Albaluce pianse per il dolore. Le sue lacrime, toccando terra, diedero in dono una vite con grappoli di succosa uva bianca. Nacque così l’Erbaluce.
IL NERETTO DI SAN GIORGIO: Il Neretto di San Giorgio (Nerèt ‘d San Giors) è un vitigno coltivato da molti secoli nel Canavese, in particolare nelle zone di San Giorgio, Bairo e Valperga. Un tempo molto diffuso, oggi la sua coltivazione è ridotta a pochi ettari: la sua produttività modesta e incostante, quindi poco redditizia, ne ha causato l’abbandono in favore di vitigni più produttivi. Si tratta di uno dei vitigni autoctoni più particolari. Non somiglia a nessun altro vino piemontese: rustico, erbaceo, con pochi tannini che lo rendono elegante e adatto all’invecchiamento. Il professor Vincenzo Gerbi lo definisce “un vino di profilo sensoriale più internazionale e meritevole di un’adeguata valorizzazione”. La storia del Neretto è stata ricostruita dalla studiosa Enza Cavallero. Sui vini del Canavese, scrisse per primo Sante Lancerio, bottigliere del papa Paolo III Farnese all’inizio del XVI secolo. Di vitigni e non solo di vini scrisse, nel 1606, Giovanni Battista Croce, gioielliere di corte Savoia, indicando il Neretto fra le uve nere che crescevano “nella montagna di Torino”. Nel 1796, anche il conte Giuseppe Nuvolone, vice direttore dell’Accademia di Agricoltura di Torino, cita quest’uva. Ma bisogna attendere il 1833 per veder descritti accuratamente i vari Neretti del Canavese, opera del medico Lorenzo Francesco Gatta. Il Neretto di San Giorgio oggi è iscritto al Catalogo Nazionale delle Varietà di Viti e si può coltivare nelle province di Torino e Vercelli. È anche conosciuto con i sinonimi dialettali di ‘d Romen, Neretin, Pcit.
IL VITIGNO NERETTO: Il Neretto è un vitigno che ha un ottimo sviluppo vegetativo, per questo necessita di forme di allevamento espanse e di una potatura lunga e ricca. Tuttavia, la produttività del Neretto non è mai molto elevata, soprattutto quando le vigne sono giovani o nelle annate più complesse, generalmente quelle in cui piove molto ai tempi della fioritura. È un’uva di ottima maturazione, poco acida e bene equilibrata. La maturazione del Neretto è media o medio-tardiva, contemporanea a quella dell’uva Barbera. A maturità, il grappolo è di medie dimensioni, cilindrico, compatto; il peduncolo ha media lunghezza. L’acino è medio/grande, ellissoidale, con una buccia abbastanza spessa e ricca di pruina, dal caratteristico colore blu/nero dalle sfumature grigiastre.
LA LEGGENDA DELLE MASCHE: A quanto pare, nella cantina dei Ciech, come ai tempi si chiamava l’azienda, giravano donne che avevano fama di essere delle masche, le streghe che vivono nelle campagne e nei boschi piemontesi. Queste masche abitualmente, nel pieno della notte, si trovavano con il diavolo, tra i filari e la nebbia, per consumare momenti di passione che lasciavano i segni nel terreno. È proprio per coprire questi segni che le masche piantavano viti di Neretto, un’uva scura, elegante e polposa, che davano origine a vini di grande carattere e corpo.

Fivi
Cieck è iscritta alla Fivi, la Federazione italiana vignaioli indipendenti, che riconosce come valore le aziende che hanno una filiera vitivinicola: l’uva che parte dal vigneto e arriva in bottiglia. www.fivi.it
Associazione Nazionale Le Donne del Vino
Lia è una Donna del Vino. Fa parte dell’Associazione nazionale che riunisce oltre 1200 imprenditrici. Nata nel 1988, conta tra le sue associate produttrici, ma anche ristoratrici, enotecarie, sommelier e giornaliste. www.ledonnedelvino.com
Leggi l’articolo anche su Horecanews.it