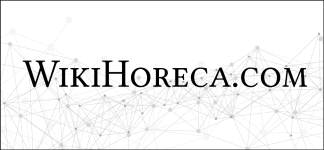Un’ossessione creativa, una passione archeologica e un’intuizione che unisce passato e futuro: nasce così Simbenia, il progetto ideato da Antonio Arcadu, artigiano industriale e modellista nuorese, capace di far parlare il vino con la voce di tremila anni fa.
Una storia sarda che si è fatta europea, partendo dall’argilla e arrivando fino ai palcoscenici internazionali dell’enologia, al Teatro gallo-romano di Dalheim, in Lussemburgo, dove l’8 maggio scorso il progetto è stato presentato in occasione della conferenza “2000 anni di storia della viticoltura nella regione della Mosella”.

Il punto di partenza di Simbenia non è una vigna, né una cantina, ma una stampante 3D. Nel 2019 Antonio Arcadu, professionista nel campo del design industriale, collabora con Wasp, azienda italiana all’avanguardia nella stampa 3D in argilla.
Lavorando con questo materiale, l’artigiano nuorese sviluppa una fascinazione crescente per le forme arcaiche delle anfore, in particolare quelle utilizzate nella vinificazione, e dà il via ad una ricerca che fonde competenze tecniche, curiosità storica e sensibilità artigiana.
Nel corso degli anni successivi approfondisce il mondo della vinificazione in terracotta, compiendo viaggi studio in Italia, Spagna, Francia, Lussemburgo e Giappone, incontra produttori, visita cantine, assaggia vini prodotti secondo metodi ancestrali.
Nel frattempo frequenta anche un corso da sommelier, che abbandona al secondo livello per seguire una sola ossessione, comprendere come le anfore potessero influenzare la fermentazione del vino e se fosse possibile riutilizzare i modelli dell’antichità.
Sant’Imbenia: la scintilla archeologica
La svolta avviene quando Arcadu si imbatte nel sito archeologico di Sant’Imbenia, nel territorio di Alghero, dove tra l’XI e l’VIII secolo a.C. fiorì un insediamento nuragico con intensi scambi commerciali nel Mediterraneo. Qui sono state rinvenute anfore di straordinaria fattura, finora considerate prevalentemente come contenitori da trasporto. Ma Arcadu ne intuisce la polifunzionalità, in particolare che potessero servire anche alla fermentazione e all’affinamento del vino.

Per trasformare questa intuizione in un progetto concreto, si affida alla competenza della professoressa Anna Depalmas, docente di Preistoria e Protostoria all’Università di Sassari, direttrice del RIPAM e tra le massime esperte di cultura nuragica.
Con il suo supporto scientifico, vengono analizzate proporzioni e caratteristiche delle anfore rinvenute, in particolare un esemplare conservato a Malaga, che ha fornito il modello di riferimento per la ricostruzione.
Dalla teoria alla pratica: nascono le anfore nuragiche moderne
Grazie agli artigiani di Artenova Terrecotte, storica fornace di Impruneta (Firenze), vengono prodotte sette anfore sperimentali in terracotta, realizzate con tecniche fedeli all’originale ma calibrate per rispondere anche alle esigenze della vinificazione moderna. Ogni anfora è un pezzo unico, risultato di un equilibrio sottile tra rigore archeologico e adattamento enotecnico.
L’aspetto più innovativo del progetto risiederebbe proprio nella possibilità di impiegare questi contenitori in tutte le fasi della vinificazione: trasporto, fermentazione e affinamento, replicando quanto ipotizzato per le anfore nuragiche originali. A quel punto, mancava solo un passo, provare concretamente se e come il vino potesse rinascere in quelle forme antiche.
La rete europea di Simbenia: vinificare in tre territori
Nel 2024 prende forma la fase sperimentale. Antonio Arcadu seleziona tre cantine che condividano lo spirito di ricerca, l’apertura alla sperimentazione e la capacità di gestire un progetto complesso. La scelta non è casuale, ma frutto di relazioni costruite nel tempo, confronti personali e visioni condivise.
La prima realtà coinvolta è Cantina Gostolai di Oliena, in Sardegna, conosciuta per il rigore analitico e la sensibilità verso le varietà autoctone, si avvicina per la prima volta alla vinificazione in anfora. Accetta la sfida con entusiasmo, utilizzando uve Arvisionadu e partecipando anche al confronto scientifico tra vinificazione in anfora e in acciaio.

La seconda tappa è il Lussemburgo, dove Arcadu incontra Corinne Kox del Domaine L&R Kox, pioniere europeo nella vinificazione in “kvevri” georgiane. La famiglia Kox, attiva da anni in progetti di valorizzazione dei metodi antichi, riconosce subito il potenziale culturale e tecnico del progetto Simbenia e vi aderisce, contribuendo a sviluppare un protocollo di vinificazione condiviso impiegando uve Auxerrois.

Infine entra nel progetto La Torretta Bio, cantina biodinamica di Grottaferrata, nei Castelli Romani, terza realtà che porta in dote l’esperienza nella gestione naturale del vigneto e l’attenzione alla sostenibilità in ogni fase produttiva. Utilizza il Trebbiano e impiega sia anfore georgiane interrate in una grotta scavata dagli etruschi alle porte di Roma sia anfore toscane la cui argilla sarà proprio quella che Arcadu utilizzerà per realizzare i nuovi prototipi dal momento che quella sarda non incontra le specifiche tecniche richieste.

Il risultato: un vino che racconta una storia lunga tremila anni
I tre vini sperimentali, prodotti in quantità limitatissima, vengono presentati per la prima volta al pubblico durante la conferenza di Dalheim. In sala, tra gli ospiti, anche l’ambasciatore italiano in Lussemburgo e rappresentanti delle istituzioni europee. Il responso? Secondo chi c’era, sorprendente. I vini presenterebbero un profilo organolettico ricco, fruttato, con una struttura complessa che colpirebbe anche i palati più esperti.

Le anfore, grazie alla loro porosità e alle geometrie calibrate, favorirebbero una micro-ossigenazione che andrebbe ad arricchire la fermentazione. Il progetto Simbenia dimostrerebbe così non solo la validità storica delle intuizioni, ma anche il potenziale pratico dell’uso moderno delle anfore nuragiche.
Le prospettive future
Il cammino di Simbenia è appena iniziato, ma già si intravedono orizzonti promettenti. Antonio Arcadu punta a trasformare le anfore nuragiche in strumenti contemporanei di vinificazione e dialogo culturale. L’idea è che possano tornare a viaggiare nel Mediterraneo non solo per trasportare vino, ma per favorire lo scambio di saperi, esperienze e pratiche sostenibili, in una piattaforma aperta, dove innovazione, archeologia e artigianato possano incontrarsi.
Sebbene il traguardo sia ancora lontano, i primi risultati indicano che la direzione è quella giusta e si proseguirà con nuove micro-vinificazioni e test in altri territori, alimentando una banca dati storica sempre più solida. E dopo l’esperienza internazionale in Lussemburgo, anticipa Arcadu, il prossimo passo sarà riportare Simbenia là dove tutto è nato, in Sardegna, per un lancio ufficiale entro la fine dell’anno che celebri le sue radici.
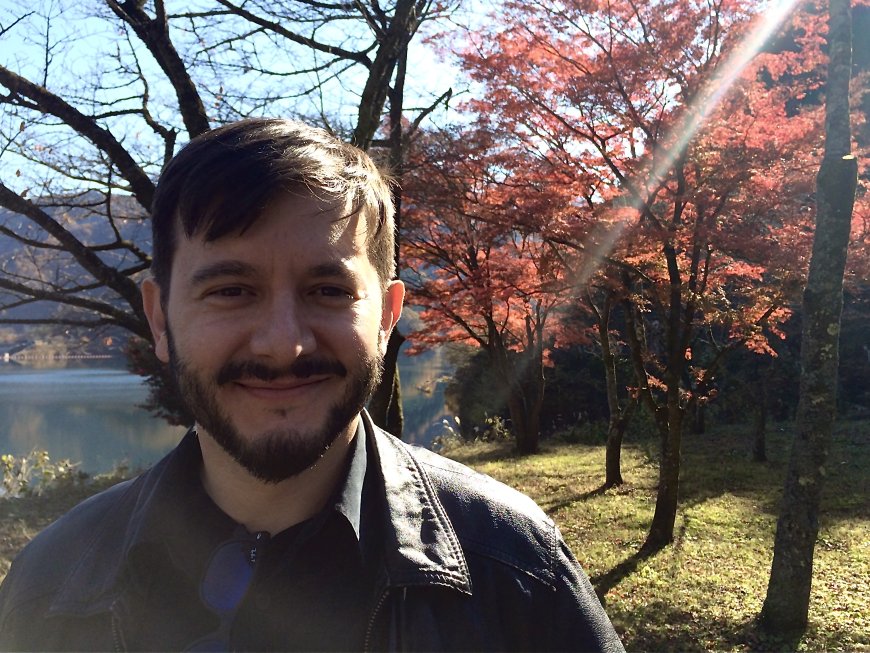
Leggi l’articolo anche su Horecanews.it